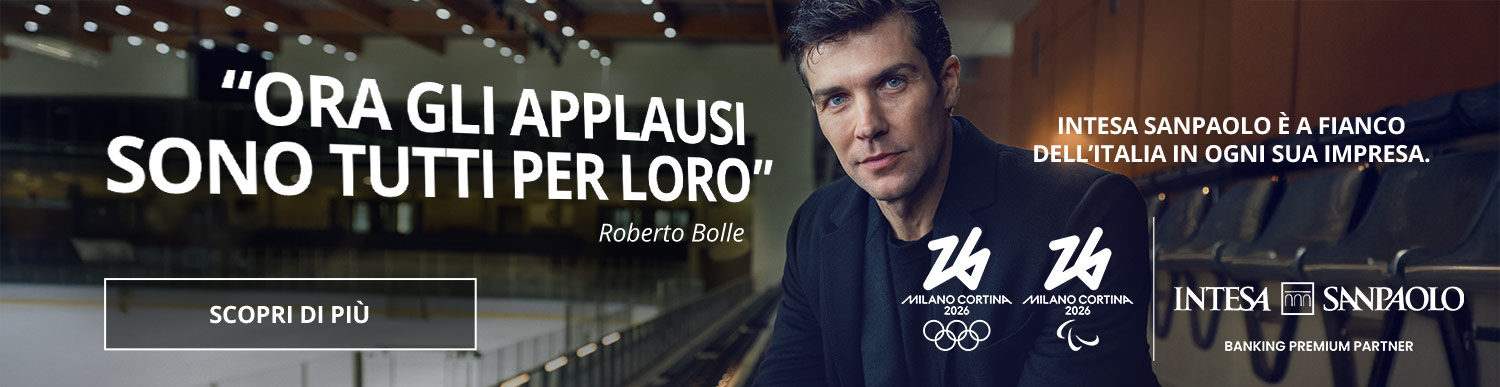Mentre la crisi umanitaria a Gaza spinge l’opinione pubblica europea a chiedere risposte più nette, l’Esecutivo comunitario guidato dalla presidente Ursula von der Leyen e dall’Alta rappresentante Kaja Kallas ha deciso di muoversi presentando un pacchetto di misure dal valore simbolico e politico, oltre che economico. L’efficacia concreta dipenderà però dal grado di unità tra gli Stati membri: senza essa le proposte rischiano di rimanere in gran parte sulla carta.
Ieri la Commissione europea ha proposto un pacchetto di misure contro Israele che include la sospensione parziale dell’accordo di associazione commerciale, il congelamento di alcuni fondi diretti e sanzioni individuali contro i due ministri ritenuti “estremisti”, Ben-Gvir e Bezalel Smotrich, e a gruppi o singoli ritenuti responsabili di incitamento all’odio e violenze nei territori palestinesi. L’iter dipende però da voti diversi – maggioranza qualificata per il commercio, unanimità per le sanzioni individuali – e rischia di arenarsi per l’opposizione di alcuni Paesi chiave.
IL PACCHETTO DI SANZIONI
La proposta della Commissione prevede tre linee principali: la possibile sospensione di parti dell’accordo di associazione Ue-Israele che garantisce preferenze tariffarie, un intervento che colpirebbe circa 5,8 miliardi € di esportazioni israeliane; la sospensione immediata di alcune voci di sostegno bilaterale stipulate tra Bruxelles e Tel Aviv; sanzioni personali, con il divieto di ingresso e congelamento di beni, a figure e associazioni coinvolte nella campagna d’aggressione nei confronti del popolo palestinese, tra cui i due ministri israeliani Ben-Gvir e Bezalel Smotrich e alcuni gruppi di coloni.
CHI POTREBBE OPPORSI (E PERCHÉ)
Il principale ostacolo all’approvazione di queste misure è la mancanza di chiarezza sulle posizioni di Italia e Germania, oltre alla prevedibile opposizione di alcuni Stati membri storicamente contrari all’applicazione di sanzioni contro Israele, come Ungheria e Repubblica Ceca e altri Paesi dell’Est.
IL NODO PROCEDURALE
Le proposte della Commissione segnano un punto di svolta politico nell’approccio europeo al conflitto, ma la loro traduzione in atti concreti si scontra con la realtà istituzionale dell’UE. La ragione pratica è semplice: la sospensione parziale dell’accordo commerciale richiede una maggioranza qualificata nel Consiglio (almeno 15 stati che rappresentino il 65% della popolazione UE) e senza il sì di Berlino e Roma quella maggioranza risulta difficile da raggiungere. Per le sanzioni individuali, invece, serve l’unanimità: basterebbe il veto di un singolo Paese.
Ciò significa che le misure di carattere amministrativo, come il congelamento dei fondi erogati dalla Commissione e la sospensione dei programmi gestiti da Bruxelles, hanno più probabilità di passare degli interventi commerciali, che necessitano dell’approvazione di Germania e Italia, o di sanzioni individuali estese, cui è probabile che si opponga almeno uno degli Stati membri.
IN GERMANIA LO SPETTRO DELL’ANTISEMITISMO
In Germania pesa la responsabilità storica e la forte sensibilità contro l’antisemitismo, fattori che rendono la classe politica cauta nel sostenere provvedimenti percepiti come troppo punitivi verso Tel Aviv, tanto che il cancelliere Merz ha avvertito pubblicamente il rischio di ricadute antisemitiche sul dibattito interno.
L’AMBIVALENZA DELL’ITALIA
L’Italia mostra invece ambivalenza: seppure il dissenso alle operazioni israeliane sia in crescita e diversi membri dell’esecutivo, compreso il ministro degli Esteri, abbiano detto di essere pronti a valutare le proposte della Commissione, l’impressione è che l’orientamento sia più quello di un’apertura al dialogo su questi temi che di un sì automatico.
IL BLOCCO DELL’EST FRENA SULLE SANZIONI A ISRAELE
Chiara invece la posizione dell’Ungheria di Viktor Orbán, che ha già mostrato in più occasioni la sua propensione al veto su pacchetti sanzionatori e la sua vicinanza politica a Israele. Riserve pratiche e politiche che emergono anche dall’Austria e dai governi di Bulgaria, Repubblica Ceca e Polonia, preoccupati per le ripercussioni diplomatiche e per gli equilibri geopolitici nel quadrante Est dell’Unione.