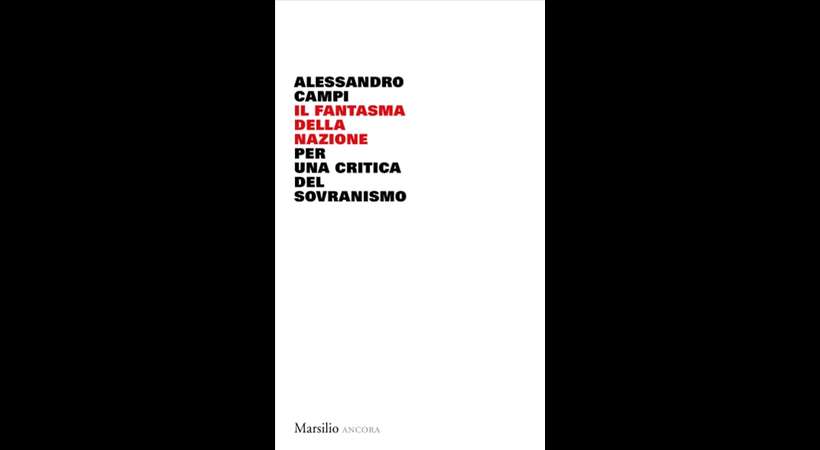“Il fantasma della nazione”: il nuovo libro del politologo Alessandro Campi sul fallimento della costruzione di un’idea moderna di nazione
Cosa vuol dire, oggi, parlare di “Nazione”? A porsi questa domanda è il politologo Alessandro Campi, nel libro “Il fantasma della nazione. Per una critica del sovranismo”, edito da Marsilio. Nel suo ultimo lavoro il professore dell’Università di Perugia si chiede cosa rimanga del concetto di “nazione”, se questa sia stata superata dalla storia e se il sovranismo altro non sia che il vecchio nazionalismo vestito con abiti più squillanti.
LA NAZIONE, LA PATRIA E L’IDENTITÀ ELETTORALE
I concetti di nazione, patria e identità sembrano essere i pilatri sui quali l’attuale destra italiana ha costruito la sua identità e riconoscibilità elettorale, portabandiera di un “sovranismo protezionista” che inneggia al ritorno a un’unità perduta, schiacciata dall’avanzata della globalizzazione. Del resto, la propaganda dell’Idea di Nazione, sembra essere il minimo comune denominatore di tutte le destre (rivoluzionaria, conservatrice, liberale, reazionaria, aristocratica, moderata, radicale, anti-moderna, populista, clericale, federalista, libertaria) apparse nel panorama europeo. “Uno dei pochi elementi che gran parte di esse ha avuto (e continua ad avere) in comune sembra essere il richiamo alla nazione come realtà storica e come mito politico fondanti l’identità di una collettività organizzata – scrive Campi -. In altre parole, le destre, pur molto diverse tra loro, sono quasi tutte variamente nazionaliste o patriottiche.
LA FORMAZIONE DELL’IDEA DI NAZIONE: UNA STORIA IN CINQUE TAPPE
Campi sostiene che l’evoluzione dell’idea di nazione ha attraversato cinque fasi. “La prima, conclusasi con la fine della Prima guerra mondiale e le convulsioni da essa prodotte – scrive il professore -, è stata caratterizzata da un nazionalismo aggressivo e colonialista, dinamico e guerrafondaio, assertivo e roboante, d’impronta industrialista e iper-modernista, ideologicamente radicale, laicista e spesso animato da sentimenti di conquista militar-territoriale, molto diverso da quello che, appena cinquant’anni prima, aveva sostenuto il processo di unificazione politica dell’Italia sulla base di un’idea di nazione che, per il fatto di essere indipendente e sovrana, non per questo si considerava esclusiva e superiore alle altre”. La seconda fase “ha coinciso con gli anni del regime fascista”. In questo periodo “il nazionalismo ha rappresentato un ingrediente importante della miscela ideologica fascista” ma “difficilmente può esserne considerato l’elemento fondamentale (tanto meno quello ideologicamente esclusivo). Il fascismo mussoliniano, dal punto di vista politico-dottrinario, si è piuttosto richiamato al mito dello Stato (in particolare nella variante etico-assolutistica teorizzata da Giovanni Gentile) inteso come soggetto politico assoluto senza il quale la nazione non può avere alcuna autonoma esistenza storica, essendo quest’ultima una creazione del primo, e all’idea di Impero (con riferimento alla tradizione classico-romana)”.
DAL DOPOGUERRA AI POPULISMI: I FALLIMENTI NELLA COSTRUZIONE DELL’IDEA DI NAZIONE
La terza fase è stata quella “dell’Italia repubblicana durante la quale non solo il nazionalismo e i richiami al sentimento patriottico sono spariti come visione o idea politica ma l’idea stessa di nazione, è caduta in una sorta di oblio politico-culturale”. In questi anni nessuna “forza politica «democratica» ha più voluto intestarsi la sua difesa o rappresentanza”. La destra rappresentata dal Msi, a causa del “trauma della sconfitta militare e della guerra civile, non è riuscita a “sviluppare un sentimento di appartenenza nazionale libero da qualunque richiamo nostalgico al vecchio regime”. La quarta fase è quella della seconda repubblica, di Mani Pulite e della scomparsa dei partiti storici. “Dalle rovine di questo terremoto istituzionale è emersa una «nuova destra» rappresentata da Silvio Berlusconi, il fondatore di Forza Italia, e dai suoi alleati: i post-fascisti di Alleanza nazionale e la Lega Nord di Umberto Bossi. Ma nessuno di questi tre partiti ha avuto un tratto ideologico nazionalista o autenticamente patriottico sul piano politico-valoriale, tanto meno è stato capace di sviluppare una riflessione originale e innovativa sull’idea di nazione e sull’Italia in quanto soggetto politico autonomo”. Quello che è mancato al leader di Forza Italia, secondo il prof. Campi, è stata “la dimensione della memoria collettiva e della profondità storica”.
CIAMPI E LA “NAZIONALIZZAZIONE” DEL CONCETTO DI PATRIA
In questo excursus si inserisce l’operato del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi che, nel corso del suo settennato, aiutò anche la sinistra a prendere confidenza con l’idea di Patria e Nazione. “Fu un presidente attivo, presente, a contatto continuo col Paese, visitandone tutte le province, e rivitalizzando le feste e le parate militari che il suo predecessore aveva messo quasi in disuso per un malinteso senso del risparmio e dell’austerità – scriveva Francesco Damato in occasione della morte del Presidente -. Non appena vedeva un tricolore sgualcito in giro per Roma o per l’Italia, Ciampi ne ordinava la sostituzione. Con lui la parola “Patria” tornò di moda”.
IL CONTRIBUTO DELLA DESTRA ITALIANA
Infine, la quinta e ultima fase, è quella che coincide con l’attualità politica “caratterizzata dall’esplosione del populismo politico e dalla crescita elettorale di forze e movimenti la cui ideologia si riassume nel cosiddetto «sovranismo»”. Spesso sbandierata, molto spesso citata nei discorsi della Premier Meloni, forse anche abusata, l’idea di nazione per molti anni è stata a esclusivo appannaggio della destra. Proprio per questa “appropriazione” dell’idea di Nazione da parte della destra, Campi, si chiede in che modo la cultura delle destre italiane abbia contribuito alla costruzione del moderno concetto di nazione. “Nella storia italiana contemporanea la parte politica che più di altre ha enfatizzato il tema della nazione e del patriottismo, la destra convenzionalmente intesa nelle sue molteplici manifestazioni politico-culturali, è anche quella che con questi concetti ha paradossalmente avuto – al di là delle parole d’ordine utilizzate e delle simbologie agitate – un rapporto per molti versi problematico e contraddittorio, quando non meramente strumentale”, scrive Campi. L’impressione del politologo è che la destra italiana, nelle sue diverse articolazioni storico-ideologiche, “non sia mai riuscita a elaborare una dottrina nazionalistica coerente e organica, in grado di saldare il richiamo all’idea di nazione con un forte senso dello Stato e di tradurre quel richiamo sul terreno della progettualità politica”.
LA “DEBOLEZZA” DEGLI ESPONENTI POLITICI DI DESTRA
La responsabilità, secondo Alessandro Campi, è da rintracciare nella “debolezza o incapacità dei suoi esponenti politico-intellettuali, molti dei quali di estrazione letteraria e dunque più inclini all’enfasi e alla solennità retorica che al rigore concettuale, ma bisogna considerare anche le ragioni storiche obiettive (e di portata generale) che contribuiscono a spiegare, almeno in parte, questo stato delle cose. Del resto, come tutte le destre politiche comparse in Europa e nel mondo “anche quella italiana ha intrecciato con il concetto di «nazione» (e con quello assimilabile di «patria») un rapporto molto stretto”. Una debolezza di mezzi ed idee che non ha permesso di “spiegare quale sia o quale possa essere la sua concreta declinazione sul piano socio-culturale e politico-istituzionale” e che rischia di “trasformarla in un fantasma, in una formula ideologica priva di sostanza politica”.